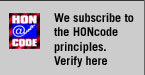La terapia farmacologica sintomatica dell’artrosi Giovanni Minisola
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia
- Ospedale di Alta Specializzazione “S. Camillo”
Azienda Ospedaliera “S. Camillo-Forlanini” - Roma
INTRODUZIONE
L’Artrosi è una malattia articolare cronica e degenerativa,
talvolta associata a sinovite.
Le numerose linee-guida per il trattamento della malattia
individuano negli analgesici e negli anti-infiammatori per
via sistemica i farmaci di primo approccio per il controllo
della sintomatologia; quelle dell’ACR (American College of
Rheumatology) sono considerate di riferimento (1).
Tra i farmaci impiegati per la terapia sintomatica figurano
gli analgesici, i FANS tradizionali e i Coxib.
La terapia con analgesici e con antiinfiammatori trova applicazione
in tutte le fasi della malattia, con lo scopo di controllare
il dolore, di migliorare la funzionalità articolare e, quindi,
di rendere più agevoli i programmi riabilitativi di mantenimento
o di recupero della mobilità delle sedi colpite.
La strategia terapeutica deve essere finalizzata ad affrontare
la malattia secondo un approccio olistico in ordine al quale
il trattamento deve essere personalizzato rispetto alle specificità
del singolo caso e deve tenere conto di tutte le possibilità
di intervento, non solo di quelle farmacologiche (fig. 1).

La terapia ottimale si fonda sulla corretta combinazione
dei vari interventi possibili, ivi compresi quelli psico-sociali,
quelli rivolti alla correzione della postura e quelli ergonomici.
L’importanza dell’approccio integrato è talvolta sottostimato
o l’approccio stesso non è applicato in modo convinto e completo;
ciò accade perché non sempre l’operatore è disponibile a
una comunicazione verbale con il paziente che può risultare
impegnativa e prolungata. Questa rassegna prenderà in considerazione
esclusivamente la terapia sintomatica attuata con farmaci
per i quali è riconosciuta un’azione antidolorifica e anti-infiammatoria
e ai quali si fa classicamente riferimento quando si parla
di terapia farmacologica sintomatica dell’artrosi.
ANALGESICI
Paracetamolo
Noto anche con il termine di acetaminofene, è il metabolita
attivo della fenacetina. Il suo meccanismo d’azione non è
ben definito, anche se sembra accertato che la brillante
azione analgesica e antipiretica dipenda dall’inibizione
selettiva a livello centrale della sintesi delle prostaglandine
(PG). La mancanza di attività sulle ciclo-ossigenasi (COX)
a livello periferico spiega la sua mancata azione anti-infiammatoria,
anche se tale caratteristica sembra essere tipica solo dei
bassi dosaggi (fig. 2).

L’impiego di questo farmaco ha avuto in passato una larga
diffusione sulla base di uno studio di confronto pubblicato
nel 1991 secondo il quale non erano evidenziabili differenze
significative nell’artrosi del ginocchio tra il paracetamolo
e l’ibuprofen. Un riesame di quello studio ed esperienze
più recenti hanno messo in dubbio quei risultati talché,
attualmente, è in corso una revisione critica circa l’impiego
del paracetamolo, specie se protratto, sia per quanto attiene
all’efficacia che per quanto riguarda la sicurezza (2).
La singola dose convenzionale per gli adulti oscilla tra
500 mg e 1 g da somministrare ad intervalli di 4-6 ore fino
al dosaggio massimo complessivo giornaliero di 4 g. Per il
paracetamolo esiste l’effetto ceiling secondo il quale, una
volta raggiunto nel singolo soggetto il massimo effetto antalgico,
questo non è ulteriormente incrementabile con l’aumento della
dose.
Alle dosi generalmente impiegate di 2-3 g al dì il paracetamolo
è ben tollerato, non danneggia la mucosa gastrica e non modifica
la funzione piastrinica. A dosi maggiori il farmaco sembra
comportarsi perifericamente come un FANS e, pertanto, è potenzialmente
gastrolesivo; esiste inoltre il rischio di danno epatico
e renale.
Il danno epatico insorge più facilmente ad alte dosi, specie
negli epatopatici e nei dediti all’alcool, e può manifestarsi
sotto forma di ittero o di epatopatia progressiva. In caso
di sovradosaggio può verificarsi una necrosi epatica acuta
che, per dosi particolarmente elevate, può essere fatale.
La tossicità renale, più rara di quella epatica, si manifesta
sotto forma di nefrite interstiziale simile a quella da fenacetina.
L’evidenza epidemiologica deve fare considerare la possibilità
di una possibile tossicità renale anche alle dosi generalmente
raccomandate.
Il paracetamolo interferisce, allungandolo, con il tempo
di protrombina e, pertanto, in corso di contemporanea somministrazione
di un anticoagulante occorre controllare più spesso l’INR.
Tramadolo
È un antagonista sintetico degli oppioidi, impiegato nei
casi resistenti al trattamento antalgico con paracetamolo.
La sua attività antidolorifica dipende dalla capacità di
legarsi ai recettori µ degli oppioidi e di inibire il re-uptake
della serotonina e della norepinefrina.
L’utilizzo del tramadolo deve essere preso in considerazione
quando la sintomatologia persiste nonostante il paracetamolo
e gli anti-infiammatori.
È disponibile in compresse da 50 mg e la dose totale giornaliera
non dovrebbe essere superiore a 300 mg, da raggiungere progressivamente
e lentamente, specie negli anziani.
Gli effetti collaterali più frequenti sono il vomito, la
nausea e le reazioni disforiche. Sembra accertato, tuttavia,
che l’insorgenza di effetti collaterali sia facilitata da
dosi iniziali elevate e, pertanto, si raccomanda l’aumento
progressivo della dose, iniziando anche con 25 mg/die. Un
effetto collaterale raro sono le convulsioni la cui incidenza
risulta più elevata nei pazienti con lupus, quando le dosi
iniziali sono elevate e quando si raggiungono rapidamente
alti dosaggi. Sono stati segnalati casi di dipendenza tra
pazienti consumatori di oppiacei.
Oppioidi
Fanno parte dell’armamentario di sostanze analgesiche impiegabili
in corso di artrosi (fig. 3).

La terapia cronica con oppioidi non ha però finora trovato
largo impiego nelle malattie reumatiche soprattutto a causa
di effetti collaterali, quali la nausea, il vomito, la
costipazione, la ritenzione urinaria, la secchezza delle
mucose, la confusione mentale e la depressione respiratoria.
Ciò nonostante gli oppioidi sono stati finora usati, sporadicamente
e per brevi periodi di tempo, in pazienti con episodi di
riacutizzazione particolarmente dolorosi e resistenti ai
trattamenti classici.
Recentemente l’APS (American Pain Society) si è espressa
a favore dell’impiego degli oppioidi anche per il controllo
del dolore non neoplastico, in pazienti selezionati. Numerosi
studi sembrano supportare adeguatamente tale posizione
(3).
Ciò sta comportando un cambiamento dell’orientamento di
pensiero circa l’impiego degli oppiodi in reumatologia
e comincia a diffondersi la tendenza a favore del loro
impiego in circostanze e casi particolari, purché ai pazienti
e ai loro famigliari venga fornita una completa informativa
circa le peculiarità di tali sostanze.
I pazienti candidati all’impiego di oppioidi sono quelli
con malattia in fase iperalgica, con dolore continuo, non
eleggibili per un intervento chirurgico e quelli nei quali
una condizione di comorbidità controindica, quanto meno
temporaneamente, l’impiego di altri farmaci (4).
Per il dolore da osteoartrosi l’oppioide ideale è quello
che assicura un effetto antalgico prolungato, un dosaggio
personalizzato e minimi effetti collaterali.
Tra i tanti oppioidi disponibili, quelli a lento rilascio
sembrano essere i più indicati. Tra questi la buprenorfina
e il fentanil a rilascio controllato transdermico consentono
una buona flessibilità di dosaggio, permettono una applicazione
ogni tre giorni e causano minori effetti collaterali rispetto
ad altri principi attivi della stessa famiglia.
Altri analgesici
La completezza dell’informazione sull’argomento obbliga a
ricordare altre sostanze anche se la loro utilità è talvolta
aneddottica, non è basata sulla medicina dell’evidenza,
non è sostenuta da studi controllati effettuati su casistiche
numerose ed è stata mutuata da esperienze positive in altri
modelli di dolore.
Tali sostanze sono l’aminofenazone, il nefopam, la noramidopirina
e il propifenazone.
Si tratta di farmaci che trovano applicazione in pazienti
già ad essi responsivi oppure per periodi di tempo limitati,
ad integrazione della terapia in corso. Alcuni di essi, inoltre,
hanno un seguito personale o nazionale che non sempre trova
conferma in altre esperienze straniere.
Il ketorolac e il dexketoprofene, tradizionalmente considerati
analgesici puri, sono in realtà FANS dotati di una buona
attività antalgica.
FANS
L’acido acetilsalicilico è stato il primo FANS impiegato
(sin dalla fine del 1800) per il trattamento di molte malattie
dolorose, tra cui quelle reumatiche. Nel 1966 l’entrata
in scena dei FANS non ne ha segnato la fine, anche se la
necessità di dovere ricorrere a più somministrazioni nella
giornata e gli effetti collaterali gastroenterici lo rendono
senz’altro meno competitivo rispetto alle “new entries”.
I FANS commercializzati successivamente all’acido acetilsalicilico
offrono rispetto a quest’ultimo alcuni vantaggi: efficacia
anti-infiammatoria e analgesica ottenibile con modalità di
somministrazione più agevoli, rapida comparsa dell’effetto
terapeutico, effetti collaterali di minore entità, migliore
tollerabilità, maggiore possibilità di scelta, maggiore accettazione
da parte dei pazienti.
I FANS vengono tradizionalmente classificati in due modi:
a seconda della classe chimica e a seconda dell’emivita.
La seconda modalità risulta più utile della prima, giacché
ha implicazioni pratiche nella scelta e nelle modalità di
somministrazione del farmaco.
La maggior parte dei FANS sono acidi organici deboli lipofilici.
Sotto il profilo chimico possono essere schematicamente suddivisi
in acidici e non acidici; in rapporto all’emivita, in FANS
a emivita breve, intermedia e lunga.
Una ulteriore classificazione prevede la loro suddivisione
in rapporto alla generazione. Tra quelli di prima generazione
figurano l’acido acetilsalicilico, l’indometacina e il fenilbutazone,
appartengono alla seconda generazione il diclofenac, il piroxicam
e il naprossene, sono di terza generazione il meloxicam,
la nimesulide e il nabumetone. Da poco sono stati commercializzati
anche in Italia l’aceclofenac e l’oxaprozina.
La classificazione dei FANS in rapporto alla generazione
fa riferimento sia all’epoca di sintesi e commercializzazione,
sia alla specifica capacità di inibire le due COX, COX-1
e COX-2.
In modo molto schematico, ma didattico, si può affermare
che i FANS di prima generazione agiscono prevalentemente
sulla COX-1, che quelli di seconda generazione sono equiattivi
nei confronti delle due COX e che quelli di terza generazione
svolgono azione inibente preferenziale nei confronti della
COX-2.
Il principale, ma non esclusivo, meccanismo d’azione dei
FANS è riconducibile, come è ben noto, alla produzione di
PG in virtù della inibizione delle COX (5).
A questo riguardo alcuni punti meritano di essere sottolineati:
l’inibizione delle COX avviene per acetilazione del sito
attivo; i FANS non antagonizzano l’attività delle PG le quali,
una volta sintetizzate, esplicano le loro azioni; l’effetto
inibitorio delle PG sulla COX piastrinica è irreversibile;
i composti salicilici non acetilati non inibiscono la sintesi
di PG e, pertanto, non esplicano gli effetti collaterali
associati a tale inibizione; i FANS inibiscono la COX piastrinica
in modo reversibile e, quindi, il recupero funzionale di
tali cellule avviene sospendendone l’esposizione al farmaco.
Quest’ultimo dato deve essere tenuto in particolare conto
quando occorre programmare la doverosa sospensione del FANS
a un paziente per il quale è previsto un trattamento chirurgico,
in ragione della interferenza negativa dei FANS sul processo
coagulativo; in tali casi occorre sospendere il FANS prima
dell’intervento; il periodo di sospensione per il singolo
farmaco è approssimativamente calcolabile moltiplicando per
cinque il numero delle ore corrispondente alla sua emivita.
Gli altri meccanismi d’azione dei FANS sono molteplici e
svolgono ruoli quantitativamente differenti a seconda dei
casi (fig. 4).
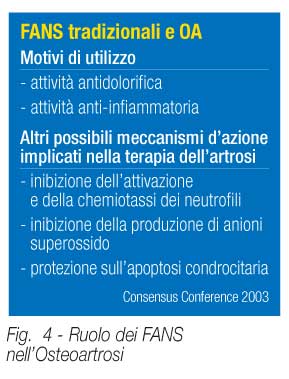
Una particolare attenzione è attualmente dedicata alla specifica
capacità inibente delle metalloproteasi di matrice (6).
Un fattore limitante la somministrazione protratta è rappresentato
dalla frequente comparsa di effetti collaterali gastroenterici
associati all’uso prolungato di FANS. La possibilità di impiego
dei Coxib, equiattivi rispetto ai FANS ma molto meno gastrolesivi,
rende possibile e sicuro un trattamento tanto efficace quanto
prolungato.
Gli effetti collaterali dei FANS, pur essendo più frequenti
a carico dell’apparato gastroenterico, della cute e del sistema
nervoso centrale, non risparmiano l’apparato cardiovascolare,
quello respiratorio, il sistema ematopoietico, il fegato
e il rene. La prevalenza di effetti collaterali da FANS è
maggiore negli anziani e nei pazienti politrattati anche
per complicanze della malattia di base o per altre malattie.
In molti casi gli effetti collaterali sono ascrivibili alla
inibizione indiscriminata delle due COX, sia pure con percentuali
di inibizione differenti verso le due isoforme a seconda
del principio attivo.
L’inibizione della COX-1 è alla base della mancata produzione
delle PG residenziali, tra cui quelle gastriche citoprotettive
della mucosa, mentre l’inibizione della COX-2 determina la
mancata produzione delle PG inducibili la cui sintesi avviene
a seguito di stimoli flogogeni.
L’inibizione delle PG regolatrici di flusso, anch’essa COX-1
mediata, è la principale causa degli effetti collaterali
dei FANS sul sistema cardiovascolare e sul rene. Possono
così comparire, specie nei soggetti anziani e a rischio,
ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia,
iperpotassiemia, insufficienza renale ed edemi (fig. 5).

È obbligatorio nei pazienti che assumono cronicamente FANS
controllare la pressione arteriosa e la funzione renale,
pronti a sospendere il trattamento se necessario. È altresì
opportuno il periodico controllo della funzione epatica e
della crasi ematica oltreché, quando indicato, della cascata
coagulativa. Come tutti i farmaci, anche i FANS possono avere
importanti effetti idiosincrasici.
Un altro importante filone di ricerca nel campo del trattamento
sintomatico delle malattie reumatiche riguarda la possibilità
di inibire contemporaneamente sia la via ciclo-ossigenasica
che quella 5-lipo-ossigenasica, responsabile della produzione
dei leucotrieni che inducono lesioni gastriche e ulcere.
Partendo dal presupposto che l’inibizione più o meno selettiva
della via ciclo-ossigenasica operi uno “shift” verso la via
lipo-ossigenasica, è stato ipotizzato che l’inibizione di
entrambi i percorsi possa tradursi in una efficace azione
terapeutica e in una elevata sicurezza gastrointestinale.
Il licofelone, capostipite della famiglia degli inibitori
di entrambe le vie, ha dimostrato negli studi finora effettuati
di essere un farmaco utile per modificare la sintomatologia
delle malattie reumatiche e ben tollerato dal sistema gastrointestinale.
COXIB
Questa classe comprende gli inibitori specifici della COX-2,
attualmente rappresentati sul mercato da celecoxib, etoricoxib
e parecoxib. I Coxib si differenziano dai FANS tradizionali
perché non inibiscono, a dosi terapeutiche, la COX-1.
Celecoxib ed etoricoxib trovano indicazione per il trattamento
sintomatico delle più comuni malattie reumatiche (7, 8).
La loro efficacia è risultata sovrapponibile a quella dei
differenti FANS di controllo utilizzati nei numerosi “randomized
clinical trials” condotti in tutto il mondo su migliaia di
pazienti affetti da patologia reumatica di tipo degenerativo
e infiammatorio.
L’aspetto più rilevante dell’impiego dei Coxib è quello relativo
alla sicurezza gastro-enterica che con questa classe di farmaci
risulta essere particolarmente elevata, consentendo il loro
impiego anche in condizione nelle quali i FANS trovano importanti
limitazioni d’uso per la presenza di fattori di rischio (fig.
6).
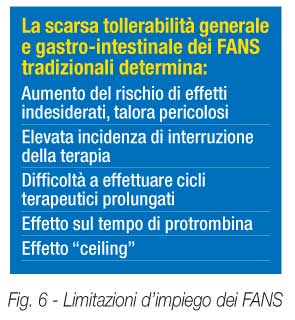
Al riguardo è stato segnalato che i pazienti con malattie
reumatiche sono particolarmente esposti al rischio di gravi
complicanze gastroenteriche da FANS tradizionali.
La sicurezza gastroenterica dei Coxib è di particolare interesse
se si considera che le complicanze gastrointestinali da FANS
hanno un rilevante impatto socio-economico, richiedono un
costante impiego di risorse economiche e sono una causa significativa
di morte tra la popolazione. Una rilevazione condotta negli
Stati Uniti ha evidenziato che il numero di morti per complicanze
gastro-enteriche provocate da FANS è superiore a quello da
altre patologie, quali il mieloma multiplo, l’asma e la malattia
di Hodgkin e che è di poco inferiore a quello per HIV e leucemia.
Studi endoscopici su larga scala hanno dimostrato che l’incidenza
di ulcere gastriche e duodenali in corso di trattamento con
i Coxib è significativamente più bassa di quella da FANS
e sovrapponibile a quella da placebo. La spiegazione di questo
dato risiede nella mancanza di inibizione della sintesi di
PG che proteggono la mucosa gastrica. Un ulteriore vantaggio
per i pazienti a rischio di sanguinamento gastrointestinale
è rappresentato dalla ininfluenza dei Coxib sull’aggregazione
piastrinica e sul tempo di sanguinamento (9).
Poiché le malattie reumatiche obbligano a un trattamento
protratto con farmaci anti-infiammatori e poiché gli effetti
collaterali gastro-enterici da FANS hanno finora rappresentato
una condizione limitante, l’impiego dei Coxib consente oggi
di attuare con maggiore sicurezza un trattamento prolungato
(fig. 7).
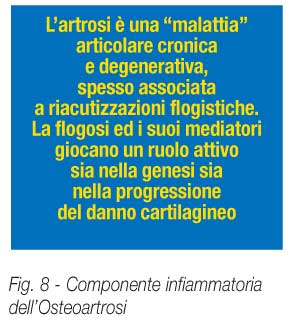
Un argomento molto dibattuto è quello relativo ai rapporti
tra COX-2 e apparati renale e cardiovascolare, entrambi
sottoposti a una fisiologica regolazione che vede coinvolte
anche PG regolatrici di flusso.
Nell’uomo la COX-2 è espressa a livello renale e la sua inibizione,
analogamente a quanto accade con FANS, potrebbe avere ripercussioni
sul flusso plasmatico renale, sul filtrato glomerulare e
sulla ritenzione elettrolitica.
L’inibizione specifica della COX-2 può indurre ritenzione
sodica e questo effetto è associato a diminuita produzione
renale di PGI2. Ne consegue che i Coxib possono causare edema
e rialzo pressorio e, sotto questo profilo, non sembrano
teoricamente differenziarsi dai FANS classici.
In considerazione del rischio di possibili eventi trombotici
cardiovascolari dopo trattamenti molto prolungati, è prudente
evitare l’impiego dei Coxib nei soggetti esposti a tale rischio.
In ogni caso, i Coxib, analogamente ai FANS tradizionali,
non devono essere somministrati a lungo e il loro utilizzo
non esime, laddove indicato, dal co-trattatamento con aspirina
a basso dosaggio.
Conclusione
Il trattamento sintomatico dell’artrosi deve essere effettuato
in modo tale da modificare la sintomatologia senza arrecare
danni al paziente e tenendo conto della componente infiammatoria
della malattia (fig.8).
Fig. 8 - Componente infiammatoria dell’Osteoartrosi
Bibliografia essenziale
1) American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis
Guidelines. Recommendations for the medical management
of osteoarthritis of the hip and knee. 2000; 43: 1905-15.
2) Garcia Rodriguez LA, Hernandez-Diaz S. The relative risk
of upper gastro-intestinal complications among users of acetaminophen
and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Epidemiology 2001;
12: 570-6.
3) A consensus statement from the American Academy of Pain
Medicine and the American Pain Society. The use of opioids
for the treatment of chronic pain. Clin J Pain 1997; 13:
6-8.
4) Katz WA. Use of nonopioid analgesics and adjunctive agents
in the management of pain in rheumatic diseases. Current
Opin Rheumatol 2002; 14: 63-71.
5) Abramson SB, Weissman G. The mechanisms of action of nonsteroidal
antiinflammatory drugs. Arthritis Rheum 1989; 32: 1-9.
6) Barracchini A, Minisola G, Amicosante G. Oxaprozin: a
NSAID able to inhibit the matrix metallo-proteinase activity.
Inflammopharmacology 2001; 9: 143-6.
7) Matucci Cerinic M. I Coxib: una nuova via terapeutica.
Celecoxib. Ann Ital Med Int 2001; 16 (suppl 3): 104S-10S.
8) Cochrane DJ, Jarvis B, Keating GM. Etoricoxib. Drugs 2002;
62: 2637-51.
9) Bombardier C, Laine L, Reicin A, Shapiro D, Burgos-Vargas
R, Davis B. et al, for the VIGOR Study Group. Comparison
of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen
in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;
343: 1520-8. |